La verifica sul piano dell’analisi storiografica dei modi in cui il rapporto dell’uomo con l’ambiente si è andato caratterizzando nel lungo corso del Medioevo risulta particolarmente interessante per la varietà di forme espresse, nelle pratiche e nelle rappresentazioni della natura, nei diversi contesti e nel succedersi dei secoli.
Ad affrontare la sfida, indagando nel suo ambito un tema di estrema attualità e al centro di una riflessione multidisciplinare che vede ripensare la categoria stessa di natura e dell’opposizione consueta cultura-natura, interviene ora il medievista Michele Campopiano.
Tenendosi metodologicamente stretto all’idea di natura come entità separata dall’agire umano e con sullo sfondo la lezione di Marc Bloch sulla centralità di forme e modi di affermazione del potere su uomini e terre come leva e motore principe nella trasformazione di territori, società e ambiente naturale. Nella stretta, interdipendente relazione che li traversa, l’autore individua nel suo stimolante volume di sintesi dedicato alla Storia dell’ambiente nel Medioevo. Natura, società, cultura, le fasi essenziali e gli snodi concettuali di questo multiforme processo (Carocci editore, pp. 173, € 17).
In prima battuta, l’eredità del mondo classico e della prima cristianità che si proietta nel Medioevo, con le sue definizioni di natura, la visione gerarchica di un cosmo che per gradi discende da Dio, la corrispondenza tra macro e microcosmo che si riproporziona nell’uomo facendone misura e compendio e significandone centralità e superiorità; ma anche nell’aspirazione pratica al controllo dell’ambiente che si intravede in filigrana nelle tracce della ripartizione dello spazio dei campi con la centuriazione anche dopo il disarticolarsi delle strutture politiche ed economiche dell’Impero.
Quindi, dopo un alto Medioevo caratterizzato da un legame di grande prossimità tra essere umano e natura in riscossa, nello snodo dei suoi secoli centrali, con il diversificarsi di paesaggi, coltivazioni e usi, anche comuni, delle risorse nelle comunità di villaggio – tra coltivi, pascoli, macchie, boschi – e l’affermarsi dell’idea di una natura come ente a sé, con una propria fisionomia che finisce spesso per essere resa in persona.
La riflessione aristotelica su una natura segnata dal movimento si orienta verso la ricerca di un ordine in quel mutamento, verso le cause seconde che regolano l’universo di cui l’uomo soltanto rileva la ratio, unico dotato, a differenza degli altri animali, di un’anima immortale. È questo ordine comune della natura che, delineatosi soprattutto nel 13° secolo, consente di distinguere il naturale dal soprannaturale: mito, miracolo, mirabilia.
Alle grandi attività di trasformazione dell’ambiente che caratterizzano i secoli centrali del Medioevo – disboscamenti e bonifiche, intensificazione di pesca e attività estrattive – corrispondono giustificazioni teoriche, teologiche e rappresentazioni ideologiche, declinate spesso a cavallo tra cura e dominio, tra colonizzazione e l’idea d’essere responsabili di un ordine da disporre, di cui esser custodi.
Volontà di controllo sul mondo naturale che intreccia dominio e desiderio di legittimazione, curiosità, sete di conoscenza, interesse per l’osservazione e la comprensione della natura. Che si traduce in regolamentazioni, norme statutarie, diritti sull’incolto o sulle acque, come pure in elaborazioni teoriche, dibattiti, manuali tecnici, trattati.
Finché le molteplici crisi del tardo Medioevo, in parte anche connesse alle sregolate pratiche di sfruttamento dell’ambiente come i disboscamenti con conseguenti dissesti idrogeologici o l’alterazione dell’equilibrio tra coltivazione e allevamento con relative riduzioni delle rese, induce una progressiva messa a fuoco del nodo della gestione delle risorse naturali.
La riflessione sull’origine di catastrofi anche naturali, alluvioni, terremoti, epidemie ed altri eventi che si fanno sempre più frequenti, vien messa in relazione, oltreché come conseguenza dei peccati dell’uomo – e assieme –, come risultato dei cambiamenti imposti da quest’ultimo all’ambiente, specialmente attraverso particolari interventi sul paesaggio.
Una consapevolezza che si traduce nei primi atti di un progressivo governo del territorio, fatto di limitazioni, regolamentazioni e fin anche pratiche preventive e nell’idea – amplificata dal processo di personificazione della natura – che essa sia comunque un agente. In grado, pertanto, di reagire a forme di sfruttamento eccessive.
Michele Campopiano, Storia dell’ambiente nel Medioevo. Natura, società, cultura, Carocci editore, pp. 173, € 17
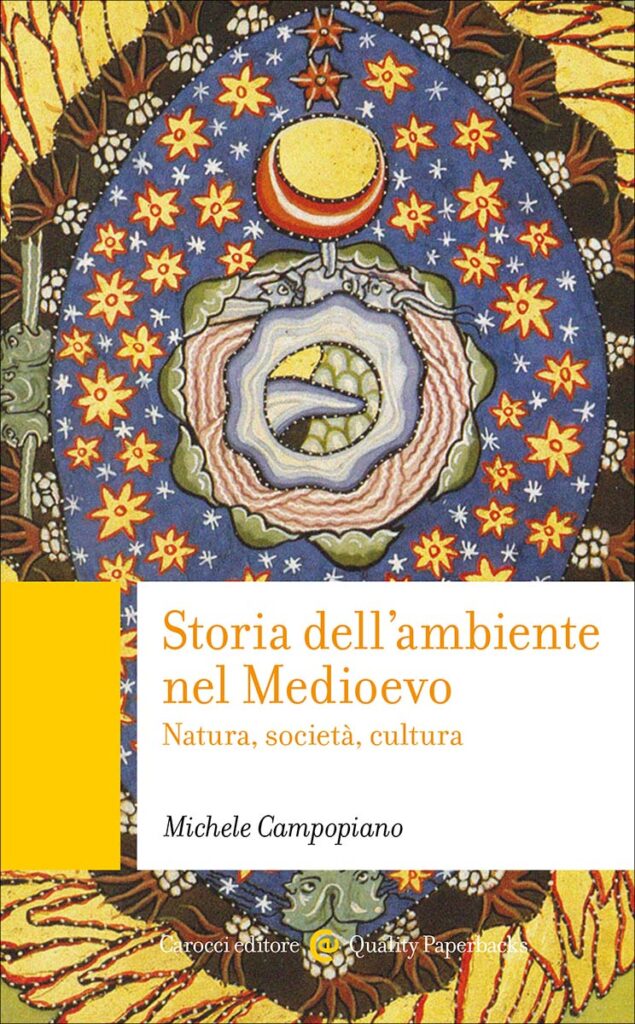
In apertura, Novembre, da Les Très Riches Heures du duc de Berry, codice miniato dei fratelli Limbourg (1412-1416), Chantilly, Musée Condé
